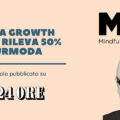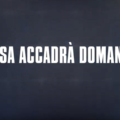Le recenti dichiarazioni di Jerome Powell a Jackson Hole hanno acceso il dibattito sulla direzione della politica monetaria americana. Alcuni osservatori, soprattutto sulla stampa, hanno letto nelle parole del presidente della Federal Reserve una resa alle pressioni politiche di Donald Trump, da tempo critico verso la linea restrittiva della banca centrale. Ma questa interpretazione appare riduttiva.
In sintesi, noi la vediamo così: Powell ha forse aspettato un po’ troppo e forse Trump non ha tutti i torti. Se avesse considerato anche la variabile affitti avrebbe dovuto abbassare i tassi da tempo. Ma il Fomc si ispira alla curva di Phillips nel prendere decisioni e sino a quando non sono arrivati segnali negativi dal mercato del lavoro non ha visto ragioni per muoversi.
Per comprendere il nostro argomento occorre richiamare il quadro teorico che guida il Fomc. La strategia della Fed si fonda, da decenni, su due ipotesi: 1. le breve periodo, esiste una relazione causale fra aspettative d’inflazione e crescita economica, quindi con il livello dell’occupazione; 2. la banca centrale può influenzare gli assetti occupazionali, attraverso operazioni di mercato aperto e annunci, i tassi di interesse a breve.
Queste ipotesi sono non poco controverse e — anzi, in molte istanze sono state falsificate e chi scrive vi è convinto — valgono soltanto per l’economia USA durante gli ultimi decenni — nondimeno esse costituiscono il pilastro teorico a partire dal quale i Fomc ragionano.
Alla luce di questo, la scelta di Powell non appare una concessione politica, ma un’applicazione ortodossa del modello classico teso per sostenere occupazione e domanda senza compromettere la stabilità dei prezzi.
Powell ha infatti motivato la possibilità di un taglio dei tassi con fattori concreti, in primo luogo i segnali di rallentamento che arrivano dal mercato del lavoro. Negli ultimi mesi la dinamica occupazionale si è indebolita in modo evidente: i nuovi posti di lavoro non agricoli sono stati appena 173mila, con consistenti revisioni al ribasso per maggio e giugno pari a – 29mila unità, tasso di disoccupazione è salito al 4,2%, tasso di partecipazione è fermo, da un lato calo delle assunzioni al blocco delle nuove aperture di posizioni fino alla riduzione del tasso di quits (le dimissioni volontarie) — confermano una domanda di lavoro in contrazione.
Anche i salari riflettono questo indebolimento. La crescita delle retribuzioni reali si attesta all’1,6% annuo, un andamento molto al di sotto della crescita reale negativa causata dall’inflazione nel periodo 2021-2023. L’indicatore reale Federal Reserve di Atlanta, che misura la dinamica salariale mensile, è sceso al 2,4%, segnalando una progressiva normalizzazione del mercato del lavoro.
Dal lato dei prezzi il pass-through delle tariffe commerciali varate dall’amministrazione Trump resta finora contenuto. L’inflazione complessiva è salita al 2,7% annuo in luglio e quella di base al 3,1%, ma i rincari nei beni direttamente importati — come abbigliamento e auto nuove — sono stati moderati, segnalando che gran parte dei costi è stata assorbita dagli importatori piuttosto che trasferita ai consumatori. Questo almeno per ora, che del doman non v’è certezza.
È questa assenza di certezza sull’effetto delle tariffe che spiega la continua cautela del Fomc sulla riduzione dei tassi.
Un elemento cruciale che a nostro avviso merita mettere in conto, riguarda la dinamica degli affitti in relazione al livello dei tassi. Questo fattore non sembra entrare nel modello analitico della Fed. Però crediamo meriti considerazione in supporto all’idea di una riduzione dei tassi. Negli ultimi dieci anni la componente affitti è stata il principale motore dell’inflazione. A luglio 2023 gli affitti risultano ancora in crescita del 3,7–3,8% su base annua, dopo un aumento complessivo superiore al 50% rispetto al 2020. Questo andamento ha inciso in modo decisivo sull’indice dei prezzi al consumo, al punto che senza la componente abitativa l’inflazione americana sarebbe stata sensibilmente più bassa.
Il meccanismo che alimenta gli affitti è legato direttamente ai tassi elevati. I mutui più cari scoraggiano il vendere: chi ha stipulato in passato un mutuo a tasso fisso molto favorevole non ha incentivo a venderne e ricomprarne a tassi elevati. È il cosiddetto effetto lock-in, che riduce drasticamente la mobilità del mercato immobiliare. Con l’offerta che langue, gli alti costi di finanziamento frenano l’avvio di nuove costruzioni, soprattutto nel segmento delle case unifamiliari.
Il risultato è una combinazione straordinariamente stagnante a fronte di una domanda abitativa in crescita sostenuta. Molte famiglie giovani, non potendo acquistare, si riversano sul mercato degli affitti, alimentando così la pressione sui canoni. In questo contesto si crea un paradosso: i tassi alti, concepiti per raffreddare l’inflazione, finiscono per alimentarla attraverso il canale degli affitti. Uno studio della Columbia Business School ha quantificato l’effetto: un aumento di 25 punti base nei tassi si traduce a un orizzonte di tre anni, in un rialzo dei canoni pari all’1,4–1,7%.
È chiaro che un taglio dei tassi, se trasmesso rapidamente ai mutui, tenderebbe a riequilibrare l’assetto del mercato immobiliare, alleggerendo la pressione sugli affitti. Questo contribuirebbe non solo a moderare l’inflazione, ma anche a migliorare l’accessibilità delle case, nei quali i costi degli immobili giocano un ruolo determinante.
In sintesi, la scelta di Powell non nasce necessariamente da un calcolo politico, bensì dalla valutazione di fattori concreti: rallentamento del mercato del lavoro, dinamica salariale in flessione e (non da ultimo, ma finora ignorato) il ruolo decisivo degli affitti come volano dell’inflazione. È in questo intreccio che va letto il possibile cambio di passo della Federal Reserve.